Siti Internazionali
Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.
Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.
Soluzione Siberiana
Come salvare il pianeta dal climate change

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Due scienziati, padre e figlio. Un'idea apparentemente folle: riportare le lancette indietro nel tempo, all'epoca dei mammut, e così combattere il riscaldamento climatico. E' il Parco del Pleistocene, a 30 chilometri da Chersky, nell'artico russo. Sul tetto del mondo. L'ANSA lo ha visitato, primo media italiano a metterci piede.
→
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Alla fine ce l’ho fatta. Ci ho messo quasi 40 anni ma sono riuscito a trovare la tana del Bianconiglio. E ci sono caduto dentro, con gioia. Solo che il paese delle meraviglie non sta nella campagna inglese - spiace per Lewis Carroll - ma a Chersky, ai confini della Yakutia, oltre il circolo polare artico russo. È qui che nel 1996 Serghei Zimov, ormai una leggenda nel suo campo, ha fondato il Parco del Pleistocene. Un’idea assurda, un mix tra esperimento scientifico e geoingegneria nonché, forse, persino azzeccatissimo investimento immobiliare. Nella tana del Bianconiglio d’altra parte realtà e sogno si fondono. Per definizione. Quel che ne esce è un mondo nuovo. Dove gli alberi sono i grandi nemici dell’uomo, il tempo a disposizione per salvare il permafrost (e dunque la nostra civiltà) è quasi scaduto e gli animali tornano a pascolare tra i ghiacci artici, così come appunto accadeva nel Pleistocene, l’era in cui da uomini abbiamo iniziato a farci dei. Mancano solo i mammut. Ma per poco. Forse, se tutto va come deve andare, fra non molto ci saranno anche quelli. Il paese delle meraviglie, appunto. Che ci offre una soluzione tangibile per fermare, o almeno mitigare, il cambiamento climatico riportando le lancette indietro nel tempo. Dunque ora bisogna mettersi comodi e seguirlo, il Bianconiglio. Perché per raccontare l’incredibile serve tempo. Ne va della vita -- la nostra.
La NESS

Volere, volare
L’Antonov AN-24 della Yakutia Airlines atterra sulla pista in terra battuta di Chersky con circa 11 ore di ritardo. Ho le orecchie disfatte da quattro ore di turboelica, il cervello annichilito dal fuso orario: la differenza con Mosca è ormai di otto ore e non saprei dire quando e quanto ho dormito veramente l’ultima volta. Il sole si sta tuffando nel fiume che costeggia l’aerodromo. M’incammino zaino in spalla verso i cancelli insieme agli altri passeggeri, quasi tutta gente del posto al ritorno dalle vacanze. Tra le mani, ben fasciate nel nastro adesivo, custodiscono intere cassette di uova. Merce rara, qui nell’Artico. Praticamente, mi dicono, una moneta parallela.
Nikita, il figlio di Serghei, mi viene incontro sorridente. Ha 35 anni, tre figlie, è alto una quaresima ed è il vero motore sia del Parco che della stazione di ricerca scientifica nord-orientale (nome in codice: NESS). È lì che ci stiamo dirigendo adesso. Fondata nel 1977, Serghei l’ha presa in mano a metà degli anni Ottanta e da allora non l’ha abbandonata più. Con la caduta dell’Unione Sovietica l’ha rilevata, ampliata, trasformata. E ora è l’unico centro di ricerca sostanzialmente privato di tutto il circolo polare artico. Nonostante sia quasi sera non fa freddo, Nikita indossa una t-shirt e una felpetta. «A luglio - racconta - abbiamo fatto lo sci d’acqua sul fiume… davvero, non sto scherzando». Ci credo. Figuriamoci. Lo leggi dappertutto che le regioni artiche si stanno surriscaldando più di ogni altra zona della terra. Ma quando ti ritrovi davvero in maglietta di sera a fine agosto a duemila chilometri dal polo nord, beh, capisci che la situazione ci sta davvero sfuggendo di mano.
Non appena mi consegnano il bagaglio (a braccia da un vecchio camion con la falce e il martello stampata sulle portiere) saltiamo a bordo della Land Rover e puntiamo verso la stazione. «Nei documentari e nei film si vede che nei parchi naturali guidano tutti queste jeep: non appena me lo sono potuto permettere ne ho comprata una», mi dice orgoglioso Nikita. Scelta azzeccata. Le strade sono un incubo. Per andare alla NESS si passa in mezzo al ‘centro’ di Chersky: un’accozzaglia di palazzi di cemento di epoca sovietica costruiti sul permafrost. Una volta qui vivevano stabilmente oltre 12mila persone; adesso poco più di 2mila. Chi può, fugge. Il governo ha investito costruendo scuola e asilo nuovi ma il settore minerario, il cuore dell’attività locale, non rende più. Gente come gli Zimov, che qui hanno costruito a modo loro un impero, non si trovano facilmente a queste latitudini. Nel tragitto verso la stazione passiamo accanto a un grande radar. Penso subito a installazioni militari top-secret -- per poter raggiungere Chersky d’altronde ho dovuto chiedere un permesso speciale all’FSB, i servizi di sicurezza eredi del KGB. Ma sono fuori strada. «Il grosso del bilancio locale - mi spiega Nikita - viene dalle tariffe di transito delle compagnie aeree: soprattutto la tratta Los Angeles-Pechino, che passa proprio sopra di noi». Insomma, dall’estrazione di carbone alle emissioni di anidride carbonica: non si può dire che il destino non abbia avuto senso dell’umorismo nei confronti di Chersky.
Ma ecco la NESS, immersa in mezzo alla taiga. Il corpo centrale, rotondo, è sormontato da una gigantesca parabola di almeno 10 metri di diametro. Inesorabilmente sovietica, nel suo design. Resto a bocca aperta perché, nell’insieme, mi sembra di essere finito sulla luna boscosa di Endor, dove è ambientato gran parte de Il ritorno dello Jedi, terzo capitolo della vecchia trilogia di Star Wars. Mancano solo gli ewok e le truppe imperiali. La stanchezza mi passa di colpo (magia di tornare bambini) e bombardo Nikita di domande. La parabola serviva per trasmettere il segnale tv al tempo dell’URSS e adesso è caduta in disuso: monumento alla gloria del passato. «Ma continuiamo a tavola, è ora di cena», ordina senza possibilità di risposta Nikita. La sala comune si trova esattamente sotto la parabola: dove un tempo dardeggiava la propaganda del regime, ora si incontrano ricercatori provenienti da tutto il mondo. La NESS, capisco in fretta, è un posto speciale. E questo è il primo miracolo degli Zimov.
Galina, la madre di Nikita, mi mostra la mia stanza. Si trova nel parallelepipedo accanto al corpo centrale, costruito da Serghei per ampliare la capienza della stazione. La dividerò con Juri Palmtag, professore associato della Northumbria University di Newcastle. Tedesco, di origine russa, svedese per adozione (la moglie e i figli vivono a Stoccolma). Giramondo per professione, nel vero senso dell’espressione. È grazie a gente come Juri se nei giornali a un certo punto leggiamo le cronache del disastro climatico in corso: sono loro che passano mese dopo mese a prelevare campioni, condurre analisi e comparare i dati. La NESS è il loro ostello e la sera la si passa a raccontare storie di artico. Davanti a birra e vodka. Un lusso che sulle prime mi sfugge -- siamo pur sempre in Russia. «Tutte le altre basi così a nord sono statali, l’alcol è proibito», mi spiega Juri. «La NESS in questo senso è unica». Nikita ne va orgoglioso, quasi più della jeep. «Chi viene qui è sempre sotto pressione, ha poco tempo per svolgere le ricerche e i vari datori di lavoro premono: è importante poter scaricare lo stress», dice. «Quest’anno sono partite 2mila bottiglie di birra e 250 di vodka… abbiamo avuto più ricercatori russi del solito e abbiamo finito tutto… ho fatto la spesa giusto oggi prima che arrivassi tu», mi confida servendo il primo giro. E scatta il brindisi.
Quella, infatti, è l’ultima sera di ‘pienone’. La stagione di ricerca sta finendo. Oltre a me e a Juri ci sono due ricercatori francesi dell’università Aix-Marseille: Eugene, dottorando, e (nientemeno) il professor Jean-Michel Claverie, virologo ambientale di fama mondiale (avete presente lo studio sui microrganismi rivitalizzati di decine di migliaia di anni fa? Ecco, lui). Poi tre ricercatori dell’università del Maine, guidati dall’italianissimo Alessandro Mereghetti. Più, naturalmente, lo staff della stazione e il clan degli Zimov al gran completo -- oltre a Nikita e a sua madre Galina si siedono a tavola la moglie Nastya, le tre figlie, e il fondatore Serghei. L’atmosfera è calda, intima. Alle pareti pendono le bandiere delle nazionalità dei ricercatori ospitati alla NESS; c’è una libreria di cortesia con titoli in inglese a disposizione di tutti; c’è una stufa in ghisa; ci sono due poltrone e un divano sormontato da una pelle d’orso. E buon cibo a volontà.
«Non è una stazione di ricerca, è un resort a cinque stelle, fidati». Alessandro e il suo team partono il giorno dopo. Naturalmente non resistiamo, parliamo in italiano e gli altri ci prendono bonariamente in giro. Scopro che sta completando un dottorato in paleo-archeologia, con un focus sulla cosiddetta steppa dei mammut. Ovvero, essenzialmente, ciò che stanno cercando di ricostruire nel Parco del Pleistocene. «È l’unico posto al mondo in cui si sta provando a fare una cosa del genere: quest’anno ci siamo venuti per cinque giorni, e abbiamo raccolto dei dati, ma probabilmente ci torneremo per un’indagine più seria». Io sono impaziente, voglio capire se l’esperimento sta funzionando, se davvero ricreando l’ecosistema dei mammut Serghei e Nikita stanno riuscendo a bloccare lo scioglimento del permafrost e, per estensione, offrire un’arma in più, economica e sostenibile, nella guerra contro il cambiamento climatico. «Funziona, funziona», assicura Alessandro. «Certo, servono più dati… io poi non sono una mammasantissima del permafrost come Nikita e Serghei, loro ti spiegheranno tutto... ma io ti posso dire che ho fatto ricerca nelle grotte della zona e le condizioni del permafrost sono pietose». Ecco, questa è la chiave per capire l’importanza del Parco. Perché se il permafrost si scongela verranno immesse nell’atmosfera quantità immani di gas serra e il climate change potrebbe assumere toni apocalittici. C’è chi dice che Serghei e Nikita siano due pazzi. Scienziati, ma pazzi. Sì, forse un pochino. Però ai miei occhi questo è un merito: non c’è progresso, senza un pizzico di follia. E stando a quel che già ho visto, ce ne fossero di matti come gli Zimov.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Lungo il Kolyma

La testimonianza di Alessandro Mereghetti
La testimonianza di Alessandro Mereghetti
Rock the Tundra
«Sì, lo so, la gente in generale ama gli alberi. Ma il problema è che non servono a niente, perlomeno qui nell’artico. Anzi, fanno più che altro danni… e sono la gioia delle zanzare». Nikita ha scelto una porzione di tundra del Parco per tenerci la sua lezione di introduzione. Forse per punirci. Le zanzare sono in effetti ovunque. Grosse. Affamate. Fastidiose. E non è nulla, mi assicura, rispetto a giugno, al principio dell’estate. In quel momento non è possibile girare senza repellenti e rete di protezione: c’è da essere spolpati vivi. Per raggiungere il Parco abbiamo fatto un’ora di barca su un tributario del Kolyma, uno dei grandi fiumi siberiani che sfociano nell’oceano artico. L’area circoscritta dalle recinzioni ormai ha toccato i 20 chilometri quadrati (su un totale di 144 del Parco intero). Al suo interno c’è il sancta sanctorum. Ovvero una zona ulteriormente cintata di 50 ettari. È la superficie originale del Parco, costantemente ‘lavorata’ dal 1996, dove principalmente vivono gli animali.
Sulle prime non pare granché: una fattoria come tante altre. Ma bisogna tenere presente che siamo a 30 chilometri da Chersky, in mezzo al nulla, circondati da vegetazione impenetrabile. Tutto, qui, è stato portato via fiume, fino all’ultimo chiodo. «La visione è di mio padre, io alla progettazione avrò contribuito al massimo per l’1%», confessa Nikita schiacciando l’ennesima zanzara. «Se parliamo di realizzazione, però, le percentuali s’invertono». Traduzione: una fatica immane. Per fortuna a Nikita il senso dell’umorismo non manca, quel gusto per la giustapposizione acida così tipico dei russi, così irresistibile. Lo vedi, nei suoi occhi, quel velo di dubbio che fa sempre capolino in chi ha dedicato la sua vita al sogno di un altro. E che solo ora ne sta raccogliendo i frutti. Lo senti netto e preciso lo sforzo per costruire la casupola centrale, dove adesso vivono stabilmente (tutto l’anno) tre persone. E le staccionate. E la grotta scavata a colpi di piccone prima (e martello pneumatico poi) nel permafrost. Senza ancora prendere in considerazione gli animali. Gli ultimi arrivati, 11 bisonti americani comprati in Danimarca, Nikita se li è andati a prendere col camion e ha guidato 40 giorni per portarli al Parco. In tutto la fauna ora comprende 13 bisonti (americani ed europei), 15 vacche della Kalmykia, circa una decina di alci, quattro buoi muschiati, una trentina di renne, diciotto pecore, otto yak e 25 cavalli selvatici della Yakutia. La ragione di questo sforzo è la base scientifica del Parco.
«L’ecosistema del Pleistocene - spiega Nikita - era così produttivo che gli alberi non sarebbero mai potuti diventare così densi. Anche a queste latitudini. Solo quando sono arrivati gli uomini, 13mila anni fa, l’avanzata degli alberi è iniziata». Un’invasione che continua tutt’ora dato che, rispetto a 20mila anni fa, pur con tutta la deforestazione dell’epoca moderna, le foreste sono più estese di circa 10 volte. Al tempo dei mammut, insomma, a dominare era la steppa: immense distese di erba solcate da grandi erbivori, la cosiddetta megafauna. Ci pensavano loro a tenere a bada gli alberi. Un ecosistema gigantesco, ricco di biodiversità, sopravvissuto per migliaia di anni a diverse ere glaciali. Ed entrato in crisi con la conquista del pianeta da parte dell’homo sapiens. «Qui nell’Artico - continua Nikita - gli umani sono stati capaci di ridurre il livello degli erbivori di 10 volte, compromettendo la capacità degli animali di mantenere pulito il territorio e attivi i pascoli. Cespugli e arbusti hanno fatto capolino e piano piano si sono estesi, limitando l’erba disponibile. Ed ecco che, 10mila anni fa, iniziamo a vedere l’espansione della taiga e della tundra boscosa: un deserto, dal punto di vista della biodiversità. Di fatto gli alberi sono specie infestanti perché non danno nulla al territorio, non sfamano nessuno. L’ultimo dei mammut per me non è morto trafitto dalle lance, ma di fame».
Una strage, quella della megafauna, documentata di pari passo con l’arrivo degli esseri umani, in Europa come nell’America del Nord e in quella del Sud. Solo in Africa i grandi erbivori hanno resistito all’urto degli umani, evidentemente poiché ci hanno convissuto così a lungo da aver imparato a difendersi. E poi perché originari di un ecosistema diverso rispetto alla steppa. Nell’artico l’arrivo degli alberi e la desertificazione della biosfera ha portato invece un nuovo equilibrio climatico. Potenzialmente catastrofico ora che la terra si sta surriscaldando. Gli alberi infatti perdono le foglie, diventano scuri, e quando arriva la breve estate artica attirano il sole, che per mesi splende 24 ore al giorno. «Abbiamo condotto delle ricerche e la zona boscosa produce 160 watt di energia in più per metro quadro, rispetto alle aree del parco ricoperte di erba», dice Nikita. Dunque calore. Il manto erboso, essendo più chiaro, riflette al contrario la luce. Proteggendo meglio il permafrost. L’erba poi, rispetto agli alberi, si è rivelata portentosa per sottrarre l’anidride carbonica dall’atmosfera e immagazzinarla nel sottosuolo.
«Io non dico che gli alberi sono il male assoluto», mette le mani avanti Nikita. «Parliamo dei tropici. Il clima è caldo ed è molto umido. Qui la materia organica nel terreno si degrada in fretta. I grandi alberi delle foreste pluviali hanno dunque senso perché vivono a lungo e trattengono i gas serra dentro di sé. Ma nell’artico il terreno è freddo, le radici degli alberi non penetrano a fondo, i fusti non crescono molto e dunque i dati ci dicono che la capacità massima di ritenzione di carbonio, fuori dal terreno, è di 2 chilogrammi per metro quadrato. Le radici dell’erba, al contrario, vanno in profondità, riducono l’umidità, e grazie al processo della fotosintesi il manto erboso trasferisce l’anidride carbonica dall’atmosfera al suolo, dove resta imprigionata grazie al freddo». Quindi, parlando di lotta ai gas serra, nelle regioni artiche l’erba (dunque la steppa) vince a mani basse contro gli alberi (ovvero la tundra boscosa). «Per darvi un’idea della differenza - prosegue Nikita - considerate che l’ecosistema tradizionale artico trasferisce al suolo 10-16 chilogrammi di CO2 per metro quadrato. All’interno del primo recinto del parco, dopo 20 anni, i dati parlano di una media 26 chilogrammi al metro quadro, con punte di 65 chilogrammi. La potenzialità, stimiamo, è di ben 100 chilogrammi. Nella parte esterna del parco, dove gli animali non brucano attivamente, arriviamo comunque a una media di 22 chilogrammi». Senza considerare che l’erba non è soggetta a incendi, come invece lo è la taiga -- e lo si è visto purtroppo in questa calda estate, con milioni di ettari andati in fumo. Tutta anidride carbonica immessa nell’atmosfera.
I grandi erbivori sono insomma la chiave per innescare il modello-Zimov di cui sopra. Per combattere il climate change su scala globale, dimentichiamoci allora per un attimo di auto elettriche e pannelli solari: quello che ci serve davvero è un mammut.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Dentro il Pleistocene

Jur-Artic Park
«Non ti fidare mai degli studiosi che pretendono di fare ricerca coi droni: stanno solo giocando con l’ultimo gadget». Nikita è chino sul radiocomando e dal cellulare controlla che i suoi bisonti stiano bene. Sono appena arrivati - lo scorso giugno - e non è saggio andare a disturbarli da vicino. Così me li fa vedere a distanza. Il tour del parco è finito - con me sono venuti anche Eugene e Jean-Michel - e tra le varie cose ci siamo fermati a chiacchierare in mezzo a un abbozzo di savana. Ovvero alti arbusti separati da larghi appezzamenti di manto erboso. «Non c’è un libro che ti possa spiegare come ricreare un ecosistema altamento produttivo estinto, non ce l’abbiamo il Pleistocene for dummies da consultare», scherza Nikita posando il drone e imbracciando la moka. «Il parco è un grande mosaico, andiamo per tentativi. Ma di una cosa sono certo: dammi dei mammut e in pochi anni non riconoscerai questo posto».
Detta così sembra una battuta. O un segno che gli Zimov alla fin fine pazzi lo sono davvero. O che alla NESS giri troppa vodka -- magari tutt’e due le cose insieme. In realtà Nikita fa sul serio. Il genetista di Harvard George Church, una delle personalità di spicco del movimento scientifico ‘de-extintion’, impegnato nel far campagna per riportare in vita specie chiave grazie alle moderne tecniche di clonazione, ha messo in piedi una squadra - l’Harvard Woolly Mammoth Revival team - con lo scopo dichiarato di far rinascere i mammut. Church sta attualmente usando la tecnica di ingegneria genetica CRISPR per ‘copiare e incollare’ il DNA dal genoma del mammut in colture cellulari di elefanti viventi. Ad oggi un certo numero di geni è stato riscritto con successo nelle linee cellulari dell'elefante asiatico, generando di modifica in modifica cellule sempre più simili a quelle dei mammut. «Le mutazioni per l'emoglobina, per la crescita di peli extra, per la produzione di grasso, fino ad adattamenti climatici sfumati come i canali ionici di sodio leggermente alterati nelle membrane cellulari sono già state inserite nelle linee cellulari», si legge sul sito di Revive&Restore, la «principale organizzazione di conservazione che promuove l'incorporazione di strumenti genetici nelle pratiche di conservazione standard, riunendo i laboratori accademici o commerciali e i professionisti della conservazione che lavorano nel campo». Church è stato ospite a Chersky e ha promesso a Serghei e Nikita che i primi mammut saranno donati proprio al Parco del Pleistocene. Insomma, l’ipotesi che in un futuro abbastanza prossimo Nikita possa davvero contare su dei mammut per spianare la sua porzione di taiga non è per nulla campata per aria.
Church, peraltro, non è l’unico che sta tentando di risuscitare i mammut. Jean-Michel a Yakutsk ha visitato dei laboratori che hanno scelto la strada della clonazione “classica”. Cioè partire dal DNA prelevato dai resti organici degli animali trovati nel permafrost. «In Giappone e Corea del Sud sono molto avanti in questo senso», assicura. Ma non a Yakutsk. «So riconoscere un laboratorio attrezzato per ricerche così avanzate e lì non lo sono». La corsa ad ogni modo è aperta. Church ha il vantaggio di aver scelto un approccio più pratico, forse l’unico. C’è infatti chi sostiene che la clonazione vera e propria, alla Jurassic Park per intenderci, non sia possibile perché i campioni di tessuti, dopo migliaia di anni di permanenza nel permafrost, sono troppo degradati.
Il mammut di Church, quando e se arriverà, sarà quindi una sorta di elefante asiatico modificato. Nikita, caffè servito alla buona, in tutto questo non si scompone: «Io mi accontento, mi va bene anche se me lo fanno a cinque zampe...». I tempi? Non biblici. Church si è sbilanciato e ha pronosticato di finire il lavoro «entro cinque anni». Il che ha provocato una tempesta - in rete si trovano decine di articoli al riguardo - e da allora il genetista americano è un po’ scomparso dai radar, timoroso forse di aver fatto il passo più lungo della gamba. «Conosco bene Church», confida Jean-Michel. «È davvero un genio e sono certo che ce la possa fare: ma servono molti soldi». Quanti? Jean-Michel risponde a colpo sicuro, come se avesse visto il capitolato. «Un miliardo di dollari, più o meno». Che, a ben pensarci, non è nemmeno tanto -- una colletta tra Jeff Bezos e Bill Gate e il gioco è fatto.
Certo, a guardarsi intorno, nella casupola del Parco, nulla sembra essere più distante dagli algidi laboratori d’ingegneria genetica. Qui - drone e strumenti scientifici a parte - i mezzi sono tutti low-tech, un misto tra relitti di epoca sovietica e ‘ibridi’ costruiti alla bisogna. Tipo il barchino con cui ci spostiamo: scafo in metallo di origine militare, parabrezza di una vecchia Lada rivettato e saldato, comodi sedili in pelle di una BMW. Mad Max alla russa. Non oso pensare cosa debba essere vivere qui d’inverno, quando i 25 gradi anomali lasciano spazio ai -50 e la notte polare ti piomba nel buio per tre mesi. «Non è facile, ma ha una sua poesia», filosofeggia il capo dei ‘butteri’ di Nikita. Che è russo ma si chiama Rinaldo. Dicevo: il paese delle meraviglie. Con o senza mammut.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Permafrost a Duvanny Yar

I Guardiani del Permafrost
Quando si dice la Storia viva. Ci abbiamo messo quattro ore di navigazione, lungo il Kolyma, ma davanti a me finalmente si staglia la falesia di permafrost di Duvanny Yar. È un luogo mitico per gli studiosi di tutto il mondo in almeno una dozzina di discipline, dai paleontologi ai biologi. Qui, a 130 chilometri da Chersky, il fiume ha infatti eroso le sponde e interi costoni di permafrost ricco di gas serra, o yedoma, sono esposti en plein air. Il processo in estate è continuo - il sole scalda le colonne di ghiaccio innestate nel terreno facendo crollare il suolo - e man mano che i costoni franano, sulle rive del fiume si ammassano reperti vecchi di migliaia di anni: zanne di mammut, ossa di megafauna, radici, materiale organico vario. Eugene e Jean-Michel si fermeranno qui qualche giorno per condurre le loro ricerche, Nikita tornerà a prenderli quando avranno finito. Per me è l’occasione perfetta per capire finalmente, nei minimi dettagli, che cos’è questo benedetto permafrost di cui tutti parlano.
Prima, però, ci fermiamo a far visita a un gruppo di ricercatori amici di Nikita. Sono a bordo di una barca, ormeggiati sulla riva opposta della falesia di Duvanny Yar. Pare che siano a corto di provviste e quindi portiamo loro un po’ di rifornimenti. In realtà mi sembra se la stiano cavando alla grande. L’equipaggio, oltre agli scienziati, consta anche di alcuni ‘tuttofare’ del posto. Ma, francamente, salendo a bordo è difficile dire chi sia chi. Stanislav mi dà il benvenuto brandendo un coltellaccio con cui sta pulendo una trota gigante. E si presenta come pescatore. In realtà è uno studioso dell’istituto Pushchino di Mosca. Miron invece è introdotto come «il professore». Ma è il navigatore, l’uomo che conosce il Kolyma come le sue tasche. Non è possibile rifiutare un giro di vodka e nel mentre il capitano frigge del pesce appena pescato. Le nuvole si sono diradate e il cielo è di un azzurro strabiliante. Il morale sulla barca è alto e si chiacchiera volentieri, battuta dopo battuta. È una scienza proletaria, quella che si fa qui sul Kolyma: nel fango di Duvanny Yar si sprofonda insieme.
Nikita a un certo punto mi fa capire che ce ne dobbiamo andare e mi sibila in un orecchio: «cercheranno di appiopparti del pesce, tu resisti». In effetti va proprio così. Io provo a blaterare qualcosa ma l’esuberanza di Stanislav è incontenibile e risaliamo sul nostro motoscafo con due sacchetti pieni. Nikita, quando siamo a distanza di sicurezza, ci guarda dentro e scopre uno storione. Sospira, gli occhi al cielo. Poi lo getta in acqua. «Si rischia la galera, pazzi scriteriati». E dà gas al barchino.
La falesia di permafrost, vista da vicino, è davvero impressionante. Le colonne di ghiaccio brillano al sole e a seconda dei riflessi virano tra l’argento e il blu metallizzato. Ci avviciniamo con circospezione perché il rischio di crolli improvvisi è alto: la collina emette continui scricchiolii, simili a quelli del fronte di un ghiacciaio. E per certi versi, lo è davvero. Nikita mi mostra una sezione del permafrost in cui si vedono chiaramente delle sottile linee parallele: ogni striscia rappresenta un anno di sedimentazione, in un meccanismo non dissimile da quello degli anelli degli alberi. Nel costone poi si nota chiaramente una miriade di piccole radici -- hanno tutte migliaia di anni. Lo stesso fenomeno lo avevo osservato nella grotta del Parco ma qui, a Duvanny Yar, la scala è raddoppiata per dieci e ogni dettaglio appare chiaro.
La falesia che mi trovo davanti, però, è davvero la punta dell’iceberg. Lo yedoma della Yakutia si trova in un bacino esteso quanto il Texas e, stando alle analisi dell’americana National Accademy of Sciences contiene dentro di sé più carbonio di quanto ce ne sia nell’atmosfera terrestre e nella vegetazione messe insieme. «Dovesse sciogliersi», spiega Nikita, «verranno sprigionate tante emissioni quanto ne producono gli Stati Uniti in un anno. Se va bene. Altre stime parlano del raddoppio netto di tutti i gas serra prodotti dall’uomo». Il problema è che ormai ci siamo vicino. «Quando ero piccolo - racconta Nikita - la temperatura media annuale era di -11 gradi mentre il permafrost stava a circa -7 gradi. Ora la media atmosferica è di -8 gradi, dunque 3 gradi più alta: la stessa variazione è passata nel permafrost, forse qualcosa in più. Ed è proprio questo il punto, ormai non è né perma né frost».
L’analisi di Nikita fa il paio con le storie che circolano alla NESS. Allora mi vengono in mente le parole di Juri, che tra una notte in bianco e l’altra mi ha raccontato della sua ultima missione in Groenlandia. Due settimane, dice, passate in magliettina, tra laghetti idilliaci e vegetazione riarsa dal sole. «Mai visto nulla del genere, a 10 chilometri dalla banchisa». Peccato che di mai in mai si sia arrivati alla norma, alla variabile costante. «Nella nostra regione - attacca Nikita - la punta più fredda del permafrost arriva a -4 gradi, ma la media è tra i -2 e i -1. Il permafrost è più caldo rispetto all’atmosfera perché in estate il calore penetra nel terreno e poi, quando arriva la neve, resta intrappolato: senza neve non ci sarebbero variazioni tra il sopra e il sotto». E qui entrano in gioco gli animali, che pestando la neve la compattano e creano dei canali di comunicazione, raffreddando così il suolo. «Nel Parco - assicura Nikita - il permafrost ha una temperatura inferiore di 2-3 gradi rispetto alle zone esterne dove non ci sono gli animali».
Il Parco del Pleistocene dunque funziona. Mentre facciamo ritorno alla NESS, planando sulle onde del grande fiume, non posso fare a meno di pensare alle implicazioni che il modello-Zimov potrebbe avere a livello planetario, se solo ci fosse davvero la volontà di fare qualcosa di serio per fermare l’apocalisse a cui stiamo andando incontro felici e beati. Da qui in poi, infatti, le buone notizie finiscono. Nikita, non appena sbarcati, mi indica una delle case che sorgono sul promontorio dirimpetto alla stazione di ricerca. «Lì abita mio padre, ti aspetta». Finalmente è arrivato l’incontro con il fondatore. Non che non lo abbia già conosciuto: Serghei, come dicevo, bazzica per la base a pranzo e a cena. Ma poi scompare. E se Nikita ha sempre il sorriso stampato sulle labbra, la battuta pronta, suo padre è l’esatto contrario: il volto imperscrutabile di una sfinge, la serietà fatta persona. Quindi entro a casa sua con la stessa trepidazione di Neo quando va a incontrare l’oracolo nel primo Matrix.
Trovo Serghei in cucina, intento a fumare una sigaretta chino sulla bocca aperta della stufa spenta. Mi siedo, gli scatto qualche foto, parliamo di niente per alcuni minuti. Ho una serie di domande che vorrei fargli ma la prima mi esce quasi da sola, senza veramente pensarci. Ma come ti è venuto in mente? Vedo che scava nella memoria, ma solo un poco. La risposta in realtà e pronta. «A me piace vivere nella bellezza, e l’ambiente circostante qui non è bello per niente. Mi piacciono i parchi. Come a tutti. E non è un caso. Era il panorama del Pleistocene: distese d’erba, alberi magnifici. Volevo che fosse un piacere vivere in queste zone, per me e la mia famiglia». Detta così, come risposta è alquanto deludente. Ma poi capisco che Serghei ama passare per cinico, fa parte del suo personaggio. La conversazione vira presto sul cambiamento climatico e il surriscaldamento dell’Artico. «Io sono pronto a tutto. Ho costruito le mie case sulla roccia, non il permafrost, e ho investito in chiatte galleggianti. L’aumento del livello degli oceani non mi spaventa: se il clima qui sarà più caldo la terra che possiedo varrà mille volte di più, diventerei molto ricco». La maschera da duro però cade in fretta, basta che transiti per la cucina la nipotina di mezzo (sospetto la sua preferita).
«La verità - dice serio - è che la nostra civiltà potrà sopravvivere solo se il clima resterà sostenibile in vaste parti del nostro pianeta, quindi dobbiamo essere responsabili nei confronti dei nostri nipoti e bisnipoti. Chi non ce li ha non può capire cosa sia la speranza. La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità. Negli ultimi due anni il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione. Dicevano che sarebbe avvenuto fra 100 anni. No, è già iniziato. E se il trend continua, vi dico che nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto. È un processo veloce. E stiamo parlando delle zone più fredde… figuriamoci dove la temperatura media del permafrost non è di -9 ma di -3 gradi». A parlare ora è lo scienziato, lo stesso che propose a Science nel 1998 un paper in cui descriveva l’impatto tremendo che avrebbe avuto sul clima lo scioglimento dello yedoma siberiano. Proposta non accettata. Troppo avanti coi tempi. La prova del nove viene nel 2006, quando Science contatta Serghei e gli chiede di sottoporre di nuovo il suo studio al comitato scientifico. I tempi sono maturi. E viene pubblicato. Quindi, insomma, ascoltarlo non mi parrebbe una cattiva idea. «La cosa grave - sottolinea - è che il nostro permafrost non solo è ricco di CO2 ma di metano, che è un gas serra 25 volte più potente dell’anidride carbonica. L’obiettivo ora è quello di mitigare il climate change. Prendere tempo. In 300 anni il problema sarà minore, ci saranno nuove tecnologie, si costruiranno nuove città. Ma dobbiamo iniziare ora: se agiamo in fretta, forse possiamo ridurre i danni al permafrost di 5-10 volte».
Serghei non crede infatti che il mondo possa davvero ridurre le emissioni antropiche. «Costa troppo, il capitalismo non lo permetterà», assicura. «Facciamo quindi quel che possiamo». E cioè prendere il modello-Zimov ed estenderlo ovunque sia possibile. Soprattutto in Siberia. A una condizione però. «Se ne deve occupare la comunità internazionale, perché i rischi del climate change pongono una sfida globale. Non può pensarci la Russia da sola. Anche perché il riscaldamento avvantaggerà il nostro Paese, potremmo raddoppiare il Pil». Il ragionamento, dunque, è che non si può chiedere ai tacchini di votarsi il natale. Ma c’è di più. «Mettiamo che Vladimir Putin decida di seguire l’esempio del Parco e applicarlo su vasta scala in Siberia. Gli altri paesi direbbero ‘ah, Putin vuole modificare il clima, è pericoloso’. Ecco perché ci vuole il coordinamento della comunità internazionale. Io dico: le basi scientifiche del Parco sono solide, la geoingegneria con gli animali costa poco ed è utile a vari livelli. E poi non dà profitti extra a Putin perché il clima sarà più freddo. Che volete di più...». Quel plurale è ovviamente diretto all’Occidente. «Solo degli stupidi si metterebbero a litigare con la Russia, adesso poi… c’è abbastanza spazio da noi per ospitare tutta la popolazione europea».
A registratore spento (non che Serghei ci faccia davvero caso) parliamo di altre piccole cose, di figli, di Italia, di futuro. Poi, prima di lasciarlo, provo l’urgenza di soddisfare l’ultima curiosità. Com’è che uno nato e cresciuto a San Pietroburgo decide di venire a vivere a Chersky, in una delle zone più remote e inospitali al mondo? Serghei ci pensa su. Il suo sguardo prima vaga, dopo incontra il mio, ed improvvisamente ne percepisco tutta l’intensità. Quando finalmente risponde, è una fucilata: «Perché cercavo la libertà».
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Gente del Kolyma

There and Back Again
Il mio tempo a Chersky è scaduto ma, prima di accompagnarmi all’aerodromo, Nikita trova il tempo di mostrarmi i danni causati dal riscaldamento climatico al centro abitato e ai suoi sobborghi. «Quando mio padre dice che la Russia avrà un vantaggio dal climate change non ne sono così sicuro: diciamo che soffrirà meno», dice abbarbicato al volante della Land Rover. Ci stiamo inerpicando sulle colline che guardano Chersky dove, come funghi, stanno nascendo decine di laghetti. Di nuovo, tutto a causa dello scioglimento del permafrost. Si parte da una pozza piccola poi, mano a mano che il calore aumenta per effetto di attrazione dell’acqua, la fossa si amplia e nasce il lago. Di conseguenza, certe strade sono ormai ridotte a tratturo.
In centro, se possibile, le cose vanno anche peggio. Un edificio è in parte crollato, ingoiato da una voragine apertasi nel permafrost: due anni fa si era partiti con una piccola crepa e in 24 mesi mezza collina è scomparsa. La sensazione, straniante e terrificante, è quella del conto alla rovescia. Prima di salutarci, chiedo a Nikita quali siano le prossime mosse per portare avanti il sogno del Parco, mammut a parte. Le idee ci sono - molti più erbivori e poi, non appena l’ecosistema lo permette, l’introduzione dei predatori - ma l’ostacolo sono le finanze. «Con la stazione di ricerca siamo in attivo mentre il Parco sono solo spese: per acquistare i bisonti abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding e qualcosa è arrivato», spiega Nikita. Ma, in sostanza, è tutto autofinanziato. «Mio padre conosce un consigliere di Putin», butta lì non troppo convinto. «Magari prima o poi ne esce qualcosa...». Che il Parco possa davvero allargarsi fino ad arrivare ad un’estensione sufficiente per avere un impatto sul clima è naturalmente una fantasia, è un’ipotesi che Nikita non prende nemmeno in considerazione. Pure lui, come suo padre, è pessimista sul futuro dell’umanità. Ma se Serghei aveva addotto una spiegazione di fatto marxista, Zimov il giovane opta invece per una ragione antropologica.
«Noi uomini, allo stato di natura, siamo esseri deboli: indifesi fino a 10 anni, iniziamo a riprodurci a 15. Per evolverci abbiamo dovuto trovare una nicchia. Per milioni di anni siamo stati gli spazzini dell’ecosistema, raccoglitori di ossa. Grazie ai nostri strumenti eravamo in grado di spezzarle e cibarci del midollo. Di fatto il nostro modello di sopravvivenza era acchiappa e scappa. E forse il climate change sta accadendo per questo, perché nei nostri geni c’è ancora questa fame atavica: quando vediamo una risorsa la prendiamo e la usiamo, non abbiamo dentro di noi il concetto di efficienza. C’è il petrolio? Lo estraiamo finché finisce. C’è il gas? Lo pompiamo fino all’ultima esalazione. Un branco di lupi non si comporterebbe mai così...».
Nikita mi accompagna fino ai controlli di sicurezza - l’intero aeroporto è compreso in due stanze - e si assicura che sia tutto a posto: ci stringiamo la mano e ognuno va per la sua strada. Io, mentre l’aereo decolla e vedo scomparire Chersky alle mie spalle, ho come la sensazione di aver raccolto una terribile profezia. Di quelle antiche, dove il responso è contenuto nel fraseggio stesso, misterioso e ambivalente. E ieri come oggi, ogni cosa dipende solo da noi.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Magazine
Emergenza casa a Roma: tra graduatorie ferme, tasse surreali e caos dati
In tutta Italia 650 mila famiglie aspettano un alloggio pubblico, solo nella capitale ci sono 6 mila sfratti all’anno. L’emergenza abitativa parte da lontano
Mediterraneo e biodiversità, un fragile tesoro
Sott'acqua, lungo le coste italiane, studiosi e ricercatori al lavoro per proteggere e raccontare il Mare Nostrum
Notizie ANSA Scegli l’informazione di ANSA.it
Abbonati per leggere senza limiti tutte le notizie di ANSA.it
Abbonati ora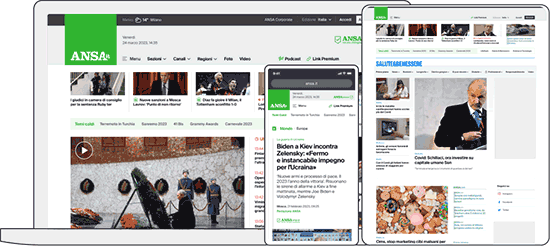
ANSA Corporate
Se è una notizia,
è un’ANSA.
Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.
Resta connesso
Ultima ora



