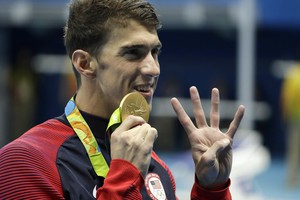Vent'anni fa ad Atlanta avevano portato a casa appena 15 medaglie e un misero, singolo oro. A Rio 2016 quelle medaglie, per gli atleti britannici, si sono moltiplicate: 67 in totale, di cui 27 del metallo piu' prezioso, un record, meglio persino del boom casalingo di Londra 2012. A poche ore dalla fine dei giochi brasiliani la Gran Bretagna gia' festeggiava un risultato storico. Nel trionfalismo piu' sfrenato di giornali e tv. Bando alla chiacchiere sull'understatement, stavolta: Liz Nichol, la numero uno dell'agenzia governativa dello sport di Sua Maesta' (creata nel 1997, proprio all'indomani del flop di Atlanta) annuncia ufficialmente il 'sorpasso' sulla Cina, colosso quest'anno in difficolta', senza speranze di podio nelle ultime competizioni. L'Union Jack, a Rio, si issa al secondo posto assoluto nelle gerarchie olimpiche, alle spalle solo degli Usa.
E il Regno Unito, in tempo di patriottismo post Brexit, torna a essere superpotenza: seppure soltanto nello sport. Un successo fatto di volti vecchi e nuovi, di melting pot multietnico, di conferma in grande stile nelle discipline piu' tradizionali dell'isola (dall'atletica di Mo Farah al nuoto, dal tennis del bicampione scozzese Andy Murray agli sport del remo), ma anche di nuovi territori di caccia semi-inesplorati come l'hockey delle ragazze. A dispetto di episodiche delusioni, ultima quella del tuffatore da copertina Tom Daley. E pazienza se qualche ombra resta: su certe improvvise ascese nell'empireo dei primati, ad esempio; o sul dominio conquistato di punto in bianco in feudi 'a rischio' come quelli del ciclismo (specialmente su pista) o dello stesso podismo di fondo. Cose di cui per ora - tanto piu' in giornate come oggi - oltre Manica si glissa. Il doping, del resto, si sa: per la stampa anglosassone di questi mesi e' solo roba da russi. O quasi.