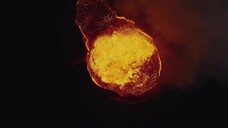Un uomo sui 65 anni con una mano tiene il fucile e con l'altra punta l'indice tracciando da lontano il percorso della technical fence, la recinzione elettrificata che lo separa dal Libano per un chilometro e duecento metri: "Ci è stato riferito che da cinque anni i miliziani hanno cominciato in segreto dall'altra parte a scavare dei tunnel per sbucare qui vicino. Noi ci addestriamo ormai quasi tutti i giorni, bisogna essere pronti", dice al cronista dell'ANSA.
Dal 7 ottobre il sud e il nord di Israele sono due poli che si attraggono, sempre più calamitati dalla paura di un nuovo attacco, stavolta dal confine col Libano, ma con gli stessi metodi usati dai terroristi quaranta giorni fa. È stato allora che venticinque membri del kibbutz di Sasa nell'area dell'Alta Galilea, zona settentrionale del Paese, hanno ricevuto la 'chiamata numero 8', una telefonata che segnala lo stato di emergenza per quei civili che improvvisamente, anche restando all'interno delle proprie case, diventano soldati. "Qui vivevano cinquecento persone, ma sono state quasi tutte evacuate e ne sono rimaste una cinquantina, per presidiare il posto e portare avanti le nostre attività", racconta Yehuda Calò Livne, neo responsabile della sicurezza del luogo. Agli uomini i kalashnikov e alle donne la pistola. Ma sua moglie, Angelica Calò Livne di origini italiane, non nasconde comunque i timori: "La nostra è l'ultima casa tra le villette a schiera del kibbutz e la prima al confine con il Libano, saremmo i più esposti nel caso di un assalto". Come se non bastasse, tre dei suoi quattro figli maschi sono stati arruolati per la guerra a Gaza.
Intanto sull'altura dell'ingresso del kibbutz gli uomini al cancello entrano ed escono dal gabbiotto impegnati dall'andirivieni di trattori e camion carichi di mele e kiwi, perché il lavoro prosegue ma ormai le misure di controllo sono simili a quelle di un check point. Del resto nel kibbutz, dopo essere stato in gran parte sfollato, c'è un via vai di militari dell'Idf, ospitati per i pasti nella mensa del villaggio e qualche momento di pausa prima di tornare fuori alle postazioni guardando a nord. I centoventi chilometri della linea blu presidiata dall'Onu che si snodano lungo la frontiera (ben cinquantadue controllati dal contingente italiano nel settore ovest) sono violati continuamente. Lo testimonia il cielo sopra Sasa, che tuona anche senza nuvole: i detriti dei razzi lanciati da Hezbollah e intercettati dall'Iron dome israeliano piovono per tutta la giornata, per fortuna distanti, mentre nelle ultime ore Israele ha ricominciato a colpire le postazioni da cui arrivano i tiri. Un clima di guerra aperta che non si vedeva dal 2006, l'anno dell'ultimo conflitto israelo-libanese. "Quattro giorni fa un razzo ha ucciso un operaio elettricista che passava a quattro chilometri da qui ed ha ferito altre persone. Impossibile tenere le famiglie e bambini ancora qui per il momento, ogni giorno restiamo chiusi per ore nei bunker", spiega Angelica.
Ma nei frutteti del villaggio di montagna verde e rigoglioso, che si oppone alla brulla pianura poco distante, continuano a lavorare oltre duecento persone, tra cui tanti arabi provenienti dai vicini villaggi, tra musulmani, cristiani e drusi. Anche la nota fabbrica del luogo non è mai rimasta chiusa: produce giubbotti anti-proiettili e sistemi di blindatura. Oggi a Sasa, ancor più di prima, la sicurezza è il core business del kibbutz.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA